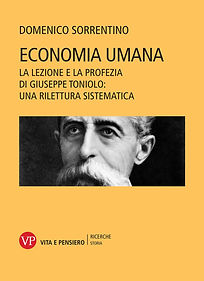ARTE CINEMA LIBRI MUSICA
• Vincenzo Alessandro
Giuseppe Toniolo:
un'altra economia è possibile
• Annamaria Iantaffi
Fredy Hirsch
e il confine della speranza
• Francesco Ottonello
Antonín Dvořák - Dal nuovo Mondo
Sinfonia n. 9 in Mi Min. Op. 95
Podcaster, già Segretario Generale
CISL Scuola Lazio


Giuseppe Toniolo:
un'altra economia è possibile
La rilettura di un economista
non mainstream, Giuseppe Toniolo,
da parte dell’arcivescovo Domenico Sorrentino. Da Toniolo la proposta
di un’economia scientifica,
ma non scientista, non individualistica ed egoistica, ma orientata verso il bene collettivo e capace di riannodare
le relazioni metodologiche e operative con le altre scienze sociali e umane.
Nell’accostarsi al libro Economia Umana, La lezione e la profezia di Giuseppe Toniolo, si rimane colpiti dalla singolarità sia dell’autore, sia dell’oggetto dell’indagine. L’autore è l’arcivescovo Domenico Sorrentino, titolare di due diocesi umbre, tra le quali quella di Assisi, di cui non occorre spiegare la centralità per il cattolicesimo italiano; l’oggetto del saggio è, invece, il pensiero economico di Giuseppe Toniolo, un economista in qualche modo “laterale” nel panorama culturale italiano, nonostante la problematica originalità del suo contributo, o, forse, proprio a causa di questa.
Si fa fatica a credere alle parole del vescovo quando, nell’introduzione, dice di sé: “Chi scrive non è un economista”. A suggerire l’ipotesi contraria non è solo la documentata ricostruzione del pensiero di Toniolo, sorretta da un poderoso apparato bibliografico e da un accurato riscontro nelle note e piè di pagina, ma anche la capacità di Sorrentino di confrontare questo pensiero con altri filoni dell’economia contemporanea, contribuendo in modo significativo all’irrisolto dibattito epistemologico su questa disciplina.
Che esista una diffusa insoddisfazione verso certe semplificazioni che permeano l’apparato concettuale dell’economia è argomento che abbiamo già affrontato nel numero 3/2023 di Scuola e Formazione Web, recensendo il volume di Chiara E. Mattei, L’economia è politica. Lì la critica era rivolta alla pretesa asetticità dell’economia, alla quale veniva contrapposta, seguendo Marx, la sua politicità effettiva, dietro cui si agita la contrapposizione di interessi diversi. Il tema si ripropone nel pensiero di Giuseppe Toniolo (1845-1918), ma da un punto di vista radicalmente diverso, stante il suo saldo riferimento alla dottrina sociale della Chiesa, alla cui definizione e al cui rafforzamento Toniolo, beatificato nel 2012, contribuì in modo decisivo.
E, tuttavia, sia l’una che l’altra impostazione convergono nel denunciare le insufficienze e le aporie del pensiero economico che si è sviluppato all’ombra dello scientismo, illuminista prima e positivista poi, fino a concepire il progetto di attribuire alla disciplina economica la stessa oggettività delle scienze naturali, a dispetto del fatto che per le scienze sociali, tra le quali l’economia rientra, non è possibile alcun riscontro sperimentale ex ante. Viviamo in un’epoca che ha ormai relativizzato e contestualizzato persino i risultati scientifici sperimentalmente verificati, ma quell’antica vocazione scientista dell’economia non è stata priva di effetti pratici, politici e dottrinali.
Il dissenso di Toniolo rispetto ai canoni dell’economia classica comincia dai fondamenti antropologici della disciplina. Egli critica la più nota delle semplificazioni su cui poggia l’economia che risale al pensiero di Adam Smith, quell’homo oeconomicus che sarebbe guidato dalla sola ricerca dell’utile, secondo i canoni della corrente utilitaristica del pensiero filosofico settecentesco.
A ciò Toniolo contrappone la complessità della natura umana, in forza della quale l’azione economica deve essere sì considerata sotto l’aspetto dell’interesse personale del soggetto economico, ma anche sotto quello opposto del suo disinteresse.
Nell’agire umano, cioè, anche in economia, si registrano diverse pulsioni e motivazioni, talvolta anche molto lontane dall’utile immediato. Per giungere a una disciplina rigorosamente definita, in luogo della schematica semplificazione che propone la visione “inglese”, smithiana, occorre rifarsi a una concezione più integrale dell’uomo, nel quale rientrano tanto la ricerca dell’utile, quanto le idee, le opinioni, il sistema di valori che ne ispirano la condotta.
C’è poi un altro errore, collegato ai presupposti antropologici della disciplina economica, ossia quello relativo alla spontanea armonia tra egoismo privato e benessere pubblico, che la scuola classica sintetizzò nella metafora della mano invisibile del mercato, secondo la quale i diversi interessi individuali trovano spontaneamente nel mercato una sintesi superiore, generando un’utilità collettiva.
Da ciò si traeva la conseguenza che la cosa migliore che lo Stato potesse fare rispetto all’economia fosse semplicemente di non intromettersi nel suo libero gioco; il proverbiale laissez faire, padre di tutti i liberismi e neoliberismi, ivi compreso quello di Ronald Reagan e dei suoi consiglieri economici, secondo i quali, in regime di libertà, il mercato avrebbe determinato, a beneficio di tutti, una ricchezza crescente che avrebbe agito come la marea montante, in grado di alzare sia il lussuoso yacht dello sceicco che il modesto gozzo del pescatore. Salvo poi riscoprire, come Keynes, e Marx prima di lui, avevano già indicato, che esistono ostacoli capaci di inceppare in modo rovinoso il meccanismo della crescita. E salvo, anche, ritrovarci a vivere in un mondo nel quale l’1% della popolazione detiene circa il 43% della ricchezza globale (Rapporto Oxfam 2024).
Spostare queste tessere determina un mosaico diverso da quello noto. Per rendersene conto, basterà rifarsi alla definizione che Toniolo dà della disciplina: l’economia è la scienza dell’ordine sociale della ricchezza. Con apprezzabile scrupolo scientifico, monsignor Sorrentino illustra in nota il carattere neoscolastico (nel senso filosofico del termine) di questa definizione, ma quanto, anche con quest’avvertenza, essa appare ricca e densa di significato a chi cerca nell’economia non la legittimazione dell’individualismo umano o la perpetuazione degli interessi dominanti, ma la sua funzione comunitaria!
Anche dal punto di vista del metodo scientifico, l’economia di Toniolo si presenta come una disciplina integrale, teorica e pratica al tempo stesso, che studia, sì, i fenomeni economici procedendo per deduzione da principi noti, ma soprattutto i fatti storici e statistici, i quali, induttivamente, portano all’individuazione delle leggi di tendenza che li spiegano.
L’economia di Toniolo è, quindi, una disciplina “pragmatica”, che procede dall’alto (i principi) e dal basso (analisi storica e statistica), riconducendo il suo metodo nell’alveo proprio delle altre scienze sociali. Esattamente il contrario di quanto un più noto economista e sociologo, Vilfredo Pareto, accusava la dottrina di Toniolo, ossia di coltivare “metafisicherie”. Accusa che potrebbe, invece, essere rivolta a certe oziose e oscure ricerche che trascurano la sostanza dell’indagine economica, il cui fine è quello di incrementare il livello di benessere della collettività e di procedere a un’equa distribuzione del prodotto sociale, non già di creare autocompiaciuti modelli matematici.
Per una lettura complessiva, peraltro molto esaustiva, del pensiero di Toniolo non si può che rimandare al saggio di monsignor Sorrentino, non senza, tuttavia, una sottolineatura finale, ineludibile in sede sindacale.
Toniolo, il cui pensiero si estende alla sociologia, di cui non si può non rilevare la stretta connessione con l’economia, fu un assertore del ruolo dei corpi intermedi. Un’indicazione di saggezza per la politica contemporanea, che da tempo ha perso di vista questo concetto fondativo della vita associata dei nostri tempi.